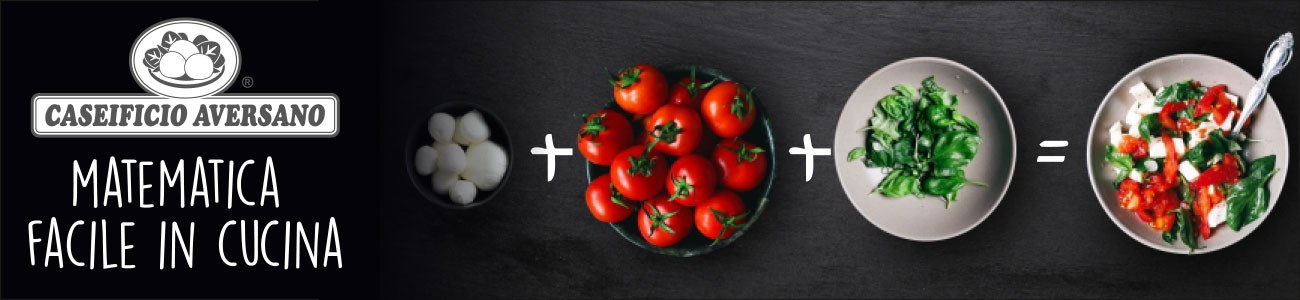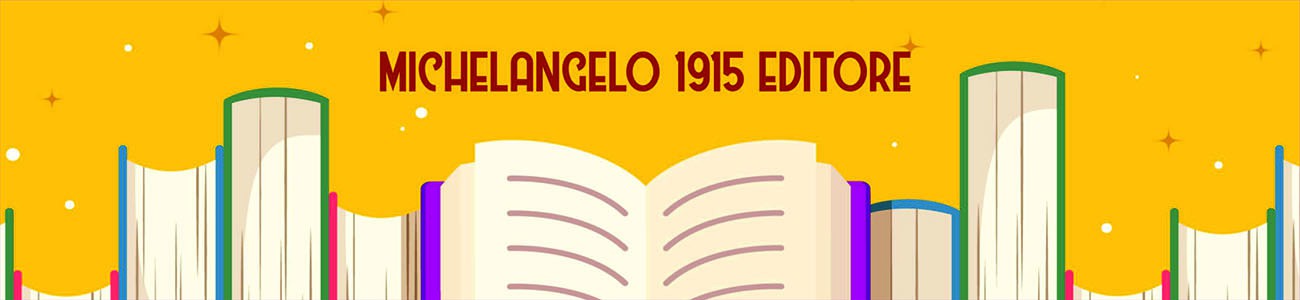IL GIORNO DELLA MEMORIA: DALLA SHOAH ALLA NAKBA
P. Gerardo Santella 20 Gennaio 2026
LA CRONACA
Il 7 ottobre 2023 Hamas, organizzazione politica e paramilitare islamista che controlla la Striscia di Gaza dal 2007 e si pone come obiettivo la liberazione della Palestina da Israele, ha condotto un attacco di grandi dimensioni contro Israele. L’ operazione ha causato la morte di circa 1400 persone e il ferimento di 3300. Numerosi i casi di rapimenti di bambini e di violenze sessuali contro donne israeliane.
La reazione israeliana, tuttora in corso, è stata altrettanto violenta. Nel maggio 2024 le forze di difesa israeliane hanno ordinato a circa un milione di palestinesi che si rifugiavano a Rafah - la città più a sud di Gaza e relativamente danneggiata - di trasferirsi nella zona della spiaggia di Mawasi, pur mancando strutture idonee a un riparo della popolazione. L’esercito ha poi distrutto gran parte di Rafah in due mesi.
Lo scontro ha sollevato la reazione pubblica internazionale. Entrambe le parti del conflitto sono state accusate di crimini di guerra. In particolare la violenta e radicale reazione di Israele è stata considerata un genocidio.
IL GENOCIDIO
Il crimine di genocidio è stato definito nel 1948 dalle Nazioni Unite come “l’intenzione di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, in quanto tale”. A differenza dei crimini di guerra o contro l’umanità, che comportano l’uccisione indiscriminata di civili come individui, il genocidio denota l’uccisione di persone in quanto membri di un gruppo, finalizzata a distruggere il gruppo stesso, impedendogli di ricostituirsi come entità politica e sociale.
Nel determinare cosa costituisca un genocidio, pertanto, dobbiamo sia stabilire l’intenzione sia dimostrare che venga attuata. L’intenzione è stata pubblicamente espressa da funzionari e leader israeliani. L’attuazione è dimostrata dalla distruzione nella striscia di Gaza (exclave de iure del territorio palestinese, che attornia la città di Gaza, confinante con Israele) non solo di abitazioni, ma anche di edifici governativi, ospedali, università, scuole, moschee, siti del patrimonio culturale, impianti di depurazione, aree agricole, parchi; e riflette una politica volta a rendere impossibile la ripresa della vita nel territorio.
Sono stati distrutti 174mila edifici, Il 70% della Striscia, sono state uccise circa 60mila persone, inclusi oltre 17 mila bambini, di cui circa mille avevano meno di un anno. Più di 2 mila famiglie sono state spazzate via, circa 6mila contano un solo sopravvissuto. 10 mila persone sono ancora sepolte sotto le macerie; 140 mila tra feriti e mutilati, tra cui il più alto numero di bambini amputati pro capite al mondo. Una intera generazione di bambini, sottoposti a continui attacchi militari, alla perdita dei genitori e a malnutrizione cronica, subirà gravi ripercussioni fisiche e mentali per il resto della propria vita. I malati poi hanno avuto scarso accesso alle cure ospedaliere.
Per definire tutto questo la parola guerra è impropria e riduttiva.
Lo slogan Mai più, riferito da parte di Israele alla decisa volontà che non accadesse mai più un’altra Shoah, è stato ridicolizzato, trasformandone il significato da una affermazione di resistenza alla disumanità, ovunque venga perpetrata, a un pretesto, perfino una carta bianca per distruggere gli altri invocando la propria passata condizione di vittime.
Israele ha sempre insistito sul fatto che qualsiasi minaccia alla sua sicurezza debba essere vista come un potenziale pericolo di una nuova Auschwitz. Questo fornisce a Israele la licenza/alibi di dipingere come nazisti coloro che percepisce come suoi nemici, un termine questo usato per tutti gli abitanti di Gaza sulla base della diffusa affermazione che “nessuno di loro è estraneo al conflitto, nemmeno i bambini che, crescendo diventerebbero militanti”.
La Shoah, invocata con insistenza da Israele come copertura dei crimini delle sue Forze di difesa, viene in tal modo deprivata della sua lezione, che richiede la promozione della tolleranza, della diversità, dell’antirazzismo, del sostegno a migranti e rifugiati, dei diritti umani.
Da qui le domande:
A che serve ricordare se le vittime di un genocidio ne compiono un altro? Se le vittime diventano carnefici?
Come possiamo raccontare la volontà nazista di sterminare la razza ebraica, senza condannare il razzismo espresso quotidianamente dalla destra ebraica estremista nei confronti dei palestinesi?
Ma facciamo prima un passo indietro nel passato.
UN PO’ DI STORIA
Il 1948 è l’anno della nascita dello Stato di Israele, ma anche l’inizio della Nakba, ovvero l’esodo forzato di centinaia di migliaia di palestinesi, e nello stesso tempo l’avvio di una frattura storica non ancora rimarginata. Le due storie, israeliana e palestinese, prendono strade opposte e drammaticamente divergenti. Da una parte, l’affermazione del sogno del sionismo , cioè di una ideologia politica il cui fine è l'affermazione del diritto alla autodeterminazione del popolo ebraico ad avere uno proprio Stato: un obiettivo perseguito attraverso la colonizzazione della Palestina storica, tentando di ottenerne un territorio il più esteso possibile e di ridurre al minimo la presenza di arabi palestinesi al suo interno.
Alla fine della Prima guerra mondiale, la Palestina era passata sotto il controllo britannico in seguito alla dissoluzione dell’Impero ottomano.
Nel corso degli anni Venti e Trenta, l’immigrazione ebraica aumentò considerevolmente, alimentata dalle persecuzioni in Europa. Questo suscitò crescenti tensioni con la popolazione araba palestinese, che vedeva nella presenza crescente degli ebrei una minaccia alla propria identità e al proprio futuro politico. Gli scontri si fecero sempre più frequenti e in una crescente radicalizzazione da entrambe le parti.
Dopo la Seconda guerra mondiale e l’orrore della Shoah, il sostegno internazionale al sionismo aumentò. Nel 1947, l’ONU approvò la risoluzione che prevedeva la partizione della Palestina in due Stati indipendenti, uno arabo e uno ebraico. La leadership ebraica accettò il piano; quella araba lo respinse, considerandolo ingiusto e inapplicabile.
Il 14 maggio 1948, poche ore prima della scadenza del mandato britannico, David Ben Gurion proclamò la nascita dello Stato di Israele. Per molti ebrei, questo momento rappresentava la realizzazione di un’aspirazione lunga duemila anni.
Ma la proclamazione avvenne in un clima di guerra. I combattimenti tra milizie ebraiche e arabe erano già in corso da mesi, e il giorno successivo, il 15 maggio, cinque Paesi arabi (Egitto, Transgiordania, Siria, Libano e Iraq) dichiararono guerra a Israele. Iniziava così la prima guerra arabo-israeliana. Israele riuscì a respingere l’attacco e a conquistare territori ben superiori a quelli previsti dal piano di partizione dell’ONU. Alla fine del conflitto, nel 1949, Israele controllava circa il 78% del territorio della Palestina.
L’esodo palestinese: le cause della Nakba
Con la guerra del 1948 ebbe inizio l’esodo di massa della popolazione palestinese. Circa 750.000 palestinesi furono costretti ad abbandonare le proprie case, villaggi e città. Un trauma profondo, vissuto come una catastrofe nazionale, che entrò nella memoria collettiva araba con il termine Nakba ( tra parentesi per un’astuzia della lingua e della storia le parole Shoah e Nakba hanno lo stesso significato e si traducono in italiano con lo stesso termine, catastrofe).
Molti palestinesi pensavano che l’esilio sarebbe durato pochi giorni o settimane. Nessuno poteva immaginare che si sarebbe trasformato in un esilio permanente.
Alla fine della guerra, Israele vietò il ritorno dei profughi palestinesi nei territori conquistati. Molti dei loro villaggi furono distrutti o riassegnati a nuovi insediamenti. I rifugiati si trovarono così in campi di accoglienza nei Paesi limitrofi - Giordania, Libano, Siria, Egitto — spesso in condizioni precarie e senza prospettive di integrazione. Nel corso del tempo si formò una diaspora palestinese che non ha mai smesso di rivendicare il diritto al ritorno. Oggi, i discendenti dei rifugiati del 1948 sono milioni. Il loro status giuridico, la memoria della perdita, e la marginalizzazione sociale in molti Paesi ospitanti, continuano a rappresentare uno degli ostacoli più complessi nei tentativi di risoluzione del conflitto. Le agenzie internazionali hanno cercato di fornire assistenza, ma la questione dei rifugiati resta irrisolta, e ogni tentativo di negoziato deve necessariamente affrontarla.
Una ferita che ancora divide
Il 1948 è un anno spartiacque: l’inizio della realizzazione di un progetto nazionale per gli uni, la distruzione di una patria per gli altri. Il sogno sionista di uno Stato per il popolo ebraico si è concretizzato, ma al prezzo di una frattura storica che ha generato sofferenze profonde e durature per il popolo palestinese.
Ancora oggi, la memoria del 1948 divide le narrazioni: da una parte, l’indipendenza israeliana celebrata ogni anno come la “Giornata dell’Indipendenza”; dall’altra, la Nakba commemorata come un lutto nazionale da milioni di palestinesi.
Il conflitto tra israeliani e palestinesi continua a essere alimentato da questa doppia origine: due popoli, due memorie, due diritti spesso vissuti come inconciliabili.
Ritorniamo al nostro discorso
LA SHOAH: AUSCHWITZ e BIRKENAU
Il 27 gennaio 2005 giornata internazionale della Memoria dell’Olocausto. Diciamo subito che il termine Olocausto è semanticamente ambiguo e che è preferibile Shoah per indicare il genocidio dei 6 milioni di ebrei attuato dai nazisti durante la seconda guerra mondiale.
Il termine Olocausto viene da olah, che vuol dire innalzamento, e si riferisce a un sacrificio cruento di un animale, di cui viene bruciato l’intero corpo. Il fumo che sale al cielo è odore gradito al Signore. Un sacrificio propiziatorio e quindi ingannevole rispetto al fenomeno storico che si vuole definire. Shoah vuol dire catastrofe, distruzione, tempesta imprevedibile e devastante, che non ha nessun significato religioso e, quindi, è parola che ben si adatta all’oggetto del nostro discorso.
Permettete ora un cenno di richiamo alla mia personale esperienza.
Sulla Shoah ho letto saggi storici, diari, memoriali, testi narrativi e poetici; ho ascoltato direttamente le parole dei testimoni del tempo, tra le quali quelle dolenti di Primo Levi; ho visto documentari, film, opere d’arte; ne ho parlato in numerose scuole del territorio (continuo a farlo), ho realizzato varie performance teatrali con la collaborazione di amici registi e attori coinvolgendo studenti delle scuole superiori.
Ho visitato in Polonia i campi di sterminio di Auschwitz e Birkenau, un viaggio di attraversamento dell’inferno dei viventi. Sono entrato e uscito da una baracca all’altra, mi sono calato nella profonda voragine del Male; ho visto immagini e oggetti che raccontano storie di dolore e orrore: terreni ricoperti da ceneri umane, reticoli di filo spinato attraversati da corrente elettrica, locali dove i medici tedeschi facevano le selezioni dei prigionieri, ma anche crudeli esperimenti sui bambini, camere a gas, forni crematori, forche per l’impiccagione, il Muro della morte, imbottito per assorbire i proiettili delle fucilazioni; barattoli di Ceikon B, da cui veniva ricavato il gas venefico, migliaia di scarpe, valige, posate, occhiali, protesi, divise da prigionieri di campo, articoli personali: berretti, vasetti di sapone, rasoi, lucido per scarpe, pettini, scodelle, due tonnellate di capelli tagliati alle donne deportate nel campo, utilizzati dall’industria tedesca per produrre coperte, calze, corde, meccanismi di accensione per le bombe, cuscini e materassi, finanche scopini per pulire gli ambienti di una nave.
A Birkenau sono salito sui vagoni di un treno i cui binari giungevano all’interno del campo, treno in cui i deportati erano trattati come bestie. Vagoni mai aperti per farli giacere nelle loro lordure, dove non venivano distribuiti cucchiai per far lambire la zuppa come i cani, cadaveri sfruttati come materia prima per ricavare oro per i denti, capelli per materiale tessile, ceneri come fertilizzante agricoli, cavie su cui sperimentare medicinali per ucciderli.
Ho visto migliaia di foto di bambini, separati dai genitori, se dopo una visita erano ritenuti adatti al lavoro, avviati al campo: se no direttamente alla camera a gas. Immagini scheletriche di deportati privati degli oggetti personali, denudati, tosati, gli si esplorava la bocca, gli si infilzava una pinza nel culo per scoprire se nascondevano gioielli, si incideva sul loro braccio un tatuaggio. Erano ridotti a bestie da marchiare e macellare.
Ho visto le baracche con cuccette, su ognuna delle quali dormivano cinque detenuti, in condizioni igieniche precarie per infestazione di pulci, cimici, pidocchi., e topi che procuravano fastidiose e talora mortali infezioni alla pelle. Sveglia, 6, 30. Poi appello, lavoro per 12 ore, salvo un’ora di pausa per il pasto: sempre la stessa brodaglia nera, con qualche torsolo di verdure e 300g. di pane per l’intera giornata. Si raccoglievano durante il percorso verso il lavoro radici e erbe mangerecce, si rovistava nella spazzatura alla ricerca di bucce di patate, pane ammuffito, avanzi di carne cruda per gli animali. Alcuni cercavano di cogliere un frutto da un albero: difficile per la sorveglianza. All’appello se mancava qualcuno, si tenevano tutti in pedi, al freddo e al gelo. Gli eventuali fuggitivi, sempre presi, erano impiccati oppure chiusi in due in un gabbiotto di un metro quadrato senza aria. Al mattino erano morti entrambi per asfissia.
Sono andato a Gerusalemme, mi sono soffermato in raccoglimento presso il Muro del pianto, dove ho infilato, secondo una tradizione centenaria, una breve preghiera di pace, scritta su un foglietto strappato al taccuino di viaggio per infilarlo in una fessura tra due blocchi di pietra.
Ho visitato in rispettoso silenzio il Memoriale della Shoah in una città, pullulante di soldati armati di mitra che ti sorvegliavano, fermavano, interrogavano, controllavano e ti raccomandavano di non prendere alcun mezzo pubblico o privato per tornare in albergo. Il rischio, reale, era che potevi incappare nell’esplosione di una bomba in un attentato terroristico. Abbiamo subito sulla strada del ritorno nel bus un lancio di pietre da parte di un gruppo di ragazzini del quartiere palestinese che gridando alzavano la mano destra facendo il segno della vittoria. Una scena che, assieme ad altri segni di lotta avevamo già visto raffigurata sui muri di edifici diroccatidiroccati Ci chiedevamo perché se la prendessero con noi innocui turisti. E non consideravamo di appartenere a uno stato occidentale colonizzatore e irresponsabile.
EMOZIONI CHE NON SI POSSONO DESCRIVERE. UNA MEMORIA CHE NON PUO’ ESSERE CANCELLATA.
Ma al calore dei sentimenti deve seguire la freddezza della elaborazione della ragione.
DA AUSCHWITZ A GAZA
La memoria della Shoah non è né israeliana né anti - israeliana. Essa non è un fenomeno del mondo ebraico destinato ai soli ebrei, ma è di tutti, per insegnare a tutti ad evitare altri genocidi, razzismi, antisemitismi. L’immagine che si vuole proporre nelle scuole e nelle istituzioni non è quella di una memoria chiusa in sé stessa, che rifiuta di aprirsi al mondo, che si ammanta del suo ruolo di vittima per negare le altre vittime.
Quale è il significato della memoria della Shoah in una realtà in cui Israele e altri paesi occidentali, che hanno fatto di essa una componente centrale della loro identità e un imperativo morale per il mondo, stanno commettendo o sostenendo un genocidio?
La Shoah è servita all’Occidente come simbolo morale è storico di ciò che esso sosteneva di rappresentare: la democrazia liberale e i diritti umani.
Ma fin dall’inizio la Shoah si è caricata di due sentimenti diversi: il primo, incarnato nello slogan MAI PIU’, con il quale il mondo si impegnava a difendere la democrazia e i diritti umani; il secondo costituito dall’empatia verso gli ebrei come vittime principali del nazismo.
Tuttavia tra questi due sentimenti c’è stata una certa tensione. Il primo appariva universale, il secondo particolare, per cui Israele era visto come lo Stato dei sopravvissuti, meritevole di ogni comprensione.
E Israele, fin dalla sua nascita nel 1948, si è allontanata dai diritti umani democratici occupando i territori palestinesi, dando vita a una segregazione coatta e violando in modo grave il loro diritto a vivere nella loro terra. Gli Ebrei europei arrivati in Palestina hanno espropriato e sfollato la popolazione palestinese indigena dal 48 al 67 e fino ai nostri giorni. La guerra del ’48 ha comportato la nascita dello Stato di Israele e ha significato la morte del popolo palestinese. Una ondata di violenza e terrore contro una popolazione di 1,3 milioni di persone causò la distruzione di 524 città e villaggi e una fuga di massa di 780 mila palestinesi. 2 milioni e 300 mila discendenti di quei primi profughi fuggiti di casa sono coloro che oggi risiedono nell’ inferno della striscia di Gaza, vittime di una nuova catastrofe umanitaria.
Nella guerra in corso il numero delle vittime civili - medici, personale dell’Onu, giornalisti vittime – è il doppio rispetto agli anni di guerra in Ucraina ed è idi molto superiore ai venti anni di guerra in Vietnam e agli otto in Iraq.
Il territorio di Gaza è stato ridotto a un terreno di caccia di esseri umani che vengono uccisi in maniera indiscriminata. Oltre 12 mila tonnellate di bombe sono state sganciate nelle prime due settimane di guerra per incenerire la metà delle abitazioni. Quelli che non sono morti sotto le macerie delle proprie case sono stati uccisi dagli elicotteri, dai droni e dai carrarmati mentre tentavano di fuggire da una regione all’altra, stanno morendo ora di malattia, di fame, di sete. Nove su dieci non mangiano tutti i giorni, in 66 giorni il sistema sanitario da 36 ospedali funzionanti si è ridotto a 11 parzialmente funzionanti. Circa 25 mila bambini hanno perduto uno o entrambi i genitori. I corpi polverizzati dei bambini palestinesi e di intere famiglie morte insieme dimostrano la brutalità di Israele, il sostegno immorale dei suoi alleati e la falsità dell’affermazione che la guerra è condotta contro il terrorismo e il fondamentalismo islamico.
Un comportamento di sanguinosa violenza già denunciato dalla Conferenza mondiale delle Nazioni unite del 2001, che condannavano Israele per atti di pulizia etnica, crimini razzisti contro l’umanità e intimavano di consentire il ritorno dei rifugiati palestinesi del 1948, di restituire loro le proprietà e risarcirli. Una deliberazione mai messa in atto per l’attentato dell’11 settembre e la guerra globale al terrorismo dichiarata dall’America di Bush.
Ma la memoria della nakba non ha generato alcuna critica ad Israele, anzi ha contribuito a giustificare il genocidio di Gaza.
Così Israele è stato ancora una volta rappresentato come vittima con l’affermazione, amplificata, che il 7 ottobre è stato il giorno più sanguinoso per gli Ebrei dal tempo della Shoah: cosa vera, ma che costruisce una falsa analogia con la Shoah, come se esistesse una continuità e un collegamento diretto tra i due eventi. E rapportati i palestinesi a nuovi nazisti, l’imperativo mai più è diventato di nuovo, il comandamento non uccidere è diventato uccidi. Così la memoria della Shoah, che doveva essere parte della soluzione è diventata fattore abilitante del genocidio, piuttosto che uno strumento contro di esso.
Il parallelo tra Nakba e Shoah, al di là dell’analogia semantica delle due parole, si impone per due ragioni: 1) l’esigenza di rendere comprensibile all’ osservatore occidentale il genocidio del popolo palestinese; 2) un interrogativo semplice: come può chi pretende di rappresentare il popolo ebraico, essendo testimone della sua tragedia, esercitare una oppressione sistematica ai danni di un altro popolo?
Inoltre la Shoah non è da considerar né un evento eccezionale né irripetibile e la sua memoria ha bisogno di far dialogare costantemente passato e presente.
UN MONITO
Il 27 gennaio è un giorno di memoria ma anche di responsabilità, di ricordo dei morti, ma anche di interrogazione dei vivi. Primo Levi ammoniva: “E’ avvenuto, quindi può accadere di nuovo”. Bisogna guardare al presente con occhi vigili, senza cedere all’illusione che certi orrori appartengono al passato. Bisogna conoscere per denunciare i segni del disumano dovunque essi si manifestano. La commemorazione della Shoah non può ignorare le sofferenze dei palestinesi; parlare di Gaza non è una provocazione, ma un atto di fedeltà alla memoria sessa. La memoria non può essere selettiva, non può chiudere gli occhi davanti all’ingiustizia, solo perché compiuta da chi un tempo è stato vittima.
Chi ha a cuore la memoria della Shoah non può non denunciare ogni massacro, ogni discriminazione, ogni logica di oppressione sistematica, ovunque e chiunque la eserciti. In nome dei morti di ieri, per proteggere i vivi di oggi e di domani.
Ricordare la Shoah e guardare a Gaza significa riaffermare un principio universale. La vita umana non ha confini etnici, religiosi o nazionali. Ogni popolo ha diritto alla dignità, alla sicurezza, alla libertà. Nessuno può essere condannato all’annientamento.
La conoscenza storica e critica – conoscere i fatti, studiarli, ascoltare le testimonianze, non dimenticare - è un antidoto contro la ripetizione del male. Conoscere ciò che accade a Gaza è un dovere. Come la memoria della Shoah, la sofferenza del popolo palestinese richiede attenzione e un impegno per porvi fine.
E noi non possiamo finire queste nostre osservazioni se non con i versi che aprono il memoriale di Primo Levi Se questo è un uomo.
Se questo è un uomo
Voi che vivete sicuri
nelle vostre tiepide case,
voi che trovate tornando a sera
il cibo caldo e visi amici:
Considerate se questo è un uomo
che lavora nel fango
che non conosce pace
che lotta per mezzo pane
che muore per un si o per un no.
Considerate se questa è una donna,
senza capelli e senza nome
senza più forza di ricordare
vuoti gli occhi e freddo il grembo
come una rana d'inverno.
Meditate che questo è stato:
vi comando queste parole.
Scolpitele nel vostro cuore
stando in casa andando per via,
coricandovi, alzandovi.
Ripetetele ai vostri figli.
O vi si sfaccia la casa,
la malattia vi impedisca,
i vostri nati torcano il viso da voi.
NOTA
Questo scritto è la sintesi ragionata di 18 articoli/saggi, di circa cento pagine complessive, selezionati dalla regista teatrale Gabriella Maiello in seguito a una ricerca su Internet. Nella riduzione, con opportune modifiche e tagli, ho cercato di dare all’elaborato un raccordo logico tra le varie parti, per favorire la comprensione degli ascoltatori.
 San Gennaro Vesuviano, Libriamoci regala emozioni e sorrisi all'Istituto Comprensivo "Cozzolino-d'Avino"
San Gennaro Vesuviano, Libriamoci regala emozioni e sorrisi all'Istituto Comprensivo "Cozzolino-d'Avino"
 Ad ogni Donna: a San Giuseppe Vesuviano una presentazione speciale per un libro speciale
Redazione
6 Marzo 2026
Ad ogni Donna: a San Giuseppe Vesuviano una presentazione speciale per un libro speciale
Redazione
6 Marzo 2026